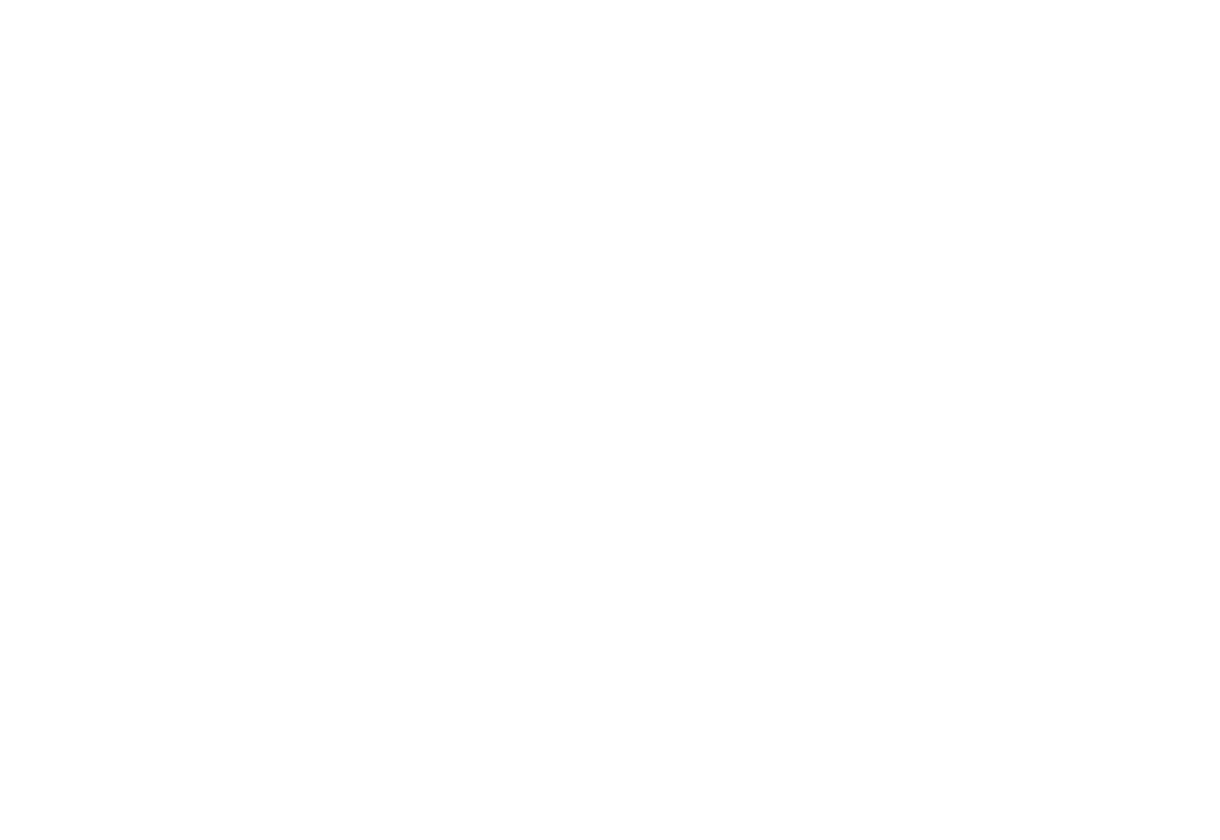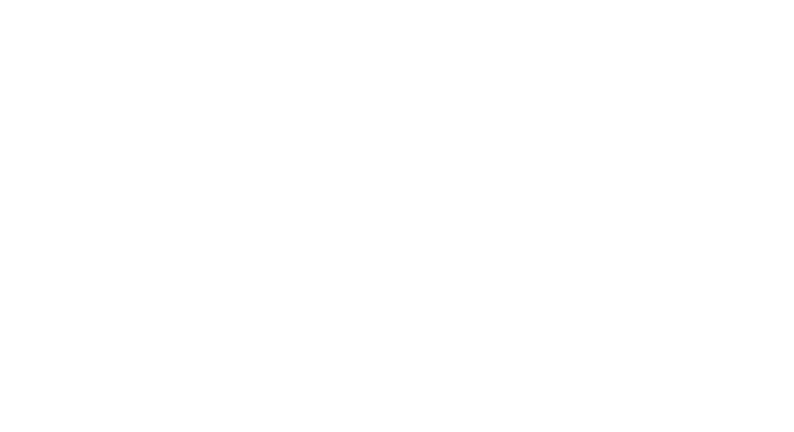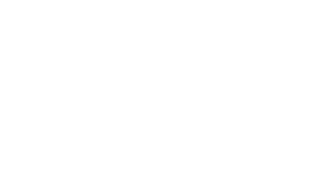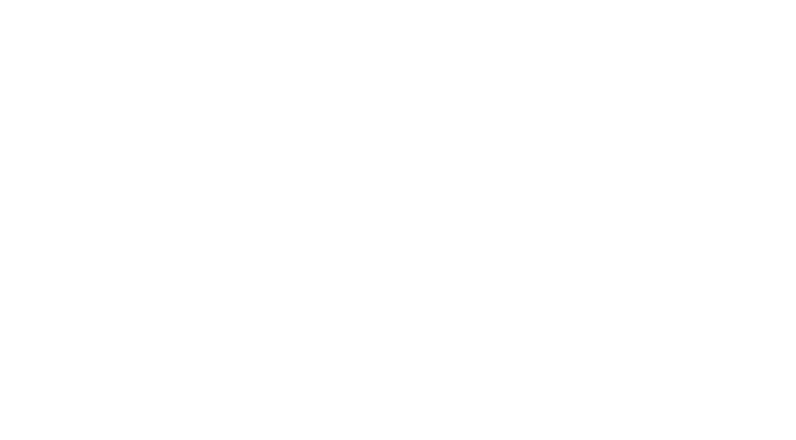Chi può tradurre Amanda Gorman? Quando si confondono letteratura e marketing
“Se ci sono testi che riflettono l’appartenenza dell’autore a una certa comunità, che ne contengono la lingua specifica, nel tradurli è necessario l’apporto di chi quella comunità la conosce bene; questo apporto è precisa responsabilità dell’editore farlo venire dal traduttore, oppure da un consulente tecnico. Ma ciò è diverso dal dire che se un autore appartiene a una certa minoranza il traduttore più adatto è una persona che appartiene a quella stessa minoranza”. Le riflessioni sul caso Amanda Gorman di chi da vent’anni lavora nell’editoria letteraria come editor e traduttrice.
Martina Testa
Negli ambienti della letteratura, dell’editoria, del giornalismo culturale si è parlato molto, negli ultimi tempi, della ventiduenne poetessa afroamericana Amanda Gorman. Innanzitutto per via del suo intervento alla cerimonia di insediamento del presidente degli Stati Uniti Joe Biden, in occasione della quale ha letto – con la ritmica e la gestualità tipiche dello spoken word – un suo testo dal titolo “The Hill We Climb”: una performance di grande impatto emotivo rilanciata dai media internazionali e dai social network. Successivamente, per via delle controversie legate alla pubblicazione in volume di “The Hill We Climb” in due Paesi europei.
Nei Paesi Bassi, l’editore Meulenhoff aveva originariamente assegnato la traduzione della poesia a Marieke Lucas Rijneveld, che dopo la vittoria dell’International Booker Prize per il romanzo Il disagio della sera è considerato uno dei maggiori talenti della nuova letteratura olandese; ma da un articolo della giornalista e attivista Janice Dieul su Volkskrant e da un tweet della performer di spoken word Zaire Krieger è nata una contestazione sui social network: si accusava l’editore di aver fatto una scelta sbagliata, preferendo un autore bianco e non-binary a svariate scrittrici e poetesse di colore che come traduttrici sarebbero state più indicate. L’editore olandese si è giustificato dicendo che la scelta di Rijnevald era stata approvata dall’autrice attraverso la sua agenzia letteraria (Writers House, di New York); in un secondo momento però Rijnevald ha rinunciato all’incarico, e l’editore ha annunciato che la traduzione sarebbe stata riassegnata.
In Catalogna, l’editore Univers aveva originariamente assegnato la traduzione a Victor Obiols, traduttore letterario di lunga esperienza; in questo caso è stata l’agenzia letteraria di Amanda Gorman a bocciare la scelta, chiedendo, secondo quanto riferito dal traduttore all’Agence France-Presse, che il lavoro venisse affidato a una donna, giovane, attivista e preferibilmente afrodiscendente.
In Italia, sui giornali e su Internet, la vicenda ha dato origine a una levata di scudi contro l’idea che “i bianchi non possano tradurre i neri”: decine di traduttori, scrittori, commentatori culturali hanno speso fiumi di parole per sostenere l’ovvia irricevibilità di questa tesi, rivendicando viceversa lo statuto della traduzione letteraria (e della letteratura stessa) come attività di mediazione, di creazione di ponti, di superamento dei recinti identitari.
Ma a me, che lavoro da vent’anni nell’editoria letteraria come editor e traduttrice, questa lettura della vicenda pare poco utile, perché sposta sul piano della letteratura quella che è invece un’operazione di marketing.
Di cosa parliamo quando parliamo di Amanda Gorman
“The Hill We Climb” non è un testo letterariamente complesso (come è facilmente verificabile leggendolo nelle versioni inglese e italiana già comparse online da settimane: ad esempio sul sito di Vanity Fair), è un testo linguisticamente abbastanza elementare che sulla pagina perde la potenza che ha nella performance; è privo di ambiguità, come del resto si richiede all’oratoria pubblica. Soprattutto, non è un testo che abbia una valenza universale: si presenta esplicitamente come un’esortazione all’unità rivolta al paese all’indomani della vittoria di Biden su Trump, il “noi” su cui è imperniata non sono “i neri”, gli afroamericani, le donne, gli oppressi del pianeta, o tutti gli abitanti del mondo: sono i cittadini degli Stati Uniti d’America del 2021. Allora perché “The Hill We Climb” si pubblica in Olanda, in Spagna, in Germania, in Catalogna, in Francia, in Svezia, in decine di paesi nel mondo, e ovviamente anche in Italia? Perché, insomma, queste 710 parole che potete leggere gratis su internet saranno in vendita per Garzanti, in un’edizione di 64 pagine a 9,50 euro?
La risposta, a mio parere, sta nella prima riga della scheda di presentazione del libro sul sito dell’editore: “I libri di Amanda Gorman sono bestseller ancora prima di essere pubblicati”. Seguono molte altre righe in cui si dichiara che i versi di “The Hill We Climb” sono un messaggio di fratellanza universale che ci sprona a “cercare la luce dietro ogni ombra”, anzi di più: a “diventare luce”; che quei versi sono “fondamentali per noi e soprattutto per i nostri figli”; una semplice lettura del testo originale basta a rivelare questa interpretazione come pretestuosa. Il punto è che il libro già si annuncia, comprensibilmente, come un colossale successo di vendite negli Stati Uniti, e nel contesto del mercato editoriale internazionale di oggi pressoché qualunque prodotto culturale di enorme successo negli Stati Uniti viene importato in maniera entusiastica, nonché spesso acritica e decontestualizzata.
In questo caso, l’agenzia Writers House, forte dell’esplosione del fenomeno Amanda Gorman negli Stati Uniti (all’indomani della performance al Campidoglio, i suoi libri sono schizzati al primo posto nella classifica di Amazon solo con i pre-order, senza neanche essere usciti) ha messo in vendita sui mercati internazionali i diritti di traduzione di un pacchetto di ben tre titoli: la famosa “The Hill We Climb” da pubblicare singolarmente; una raccolta che comprende quella e altre poesie; e un libro per bambini illustrato. In Italia si è scatenata un’asta fra vari editori (a cui è stato chiesto di presentare le offerte sulla base di un “partial manuscript” e quindi senza neanche leggere i testi completi), che si è chiusa nel giro di poche ore per cifre che solo un grosso gruppo editoriale può permettersi. Amanda Gorman, insomma, non arriva in Italia in seguito a un’operazione rigorosa e appassionata di scouting fra le migliori voci della poesia nordamericana, come ad esempio quelle che fa la piccola casa editrice di Firenze Black Coffee con le sue preziose antologie: arriva impacchettata come un prodotto commerciale da un’agenzia letteraria newyorkese che la vende a grossi editori in tutto il mondo.
La pubblicazione di “The Hill We Climb” mi appare come un esempio di un modo di fare editoria molto diffuso: intellettualmente passivo, approssimativo, spesso letteralmente suddito del mercato angloamericano e basato esclusivamente su una logica di profitto che, peraltro, sul lungo periodo mi sembra perdente in quanto non crea veri lettori. Grossi investimenti su bestseller annunciati (che, specie nel caso di esordienti, rischiano di creare brutti contraccolpi sulla carriera futura dell’autore se il successo di vendite non combacia con le aspettative), contenuti facilmente etichettabili, massima prevedibilità; l’idea di fornire al lettore, debitamente profilato, contenuti che lo compiacciano, lo rassicurino, gli riconfermino ciò che già sa o pensa di sapere. (Un vago orrore dell’ambiguità, della difficoltà, di ciò che rischia di disturbare).
Se l’operazione editoriale si configura così, non siamo più sul piano della trasmissione di un contenuto letterario, ma della diffusione commerciale di un brand: un brand fatto di gioventù, donnità, nerezza e tanto tanto successo (ah: e di un cappotto giallo); la questione della scelta del traduttore non ha a che fare con la pratica della traduzione, ma con il confezionamento del prodotto. La messa in discussione della scelta di Rijnevald da parte delle attiviste di colore olandesi, lungi dal chiamare in causa la traduttologia (del resto, non veniva da un gruppo di traduttori), mi appare più che altro assimilabile alla richiesta di essere coinvolte in una campagna pubblicitaria: associare il proprio nome al libro equivale a comparire in uno spot (l’agenzia letteraria, nell’accettare o rifiutare il traduttore, sta facendo una sorta di casting per questo spot). È come chiedere che nelle pubblicità di cosmetici non si facciano vedere solo donne bianche; come chiedere che nelle pubblicità dei detersivi compaiano gli uomini e non solo le donne. Quanto l’inclusione nell’immaginario pubblicitario contribuisca davvero al superamento delle discriminazioni e delle diseguaglianze può essere oggetto di discussione: ma almeno mi pare importante che si capisca che nel caso Gorman il campo di gioco è di fatto questo.
E mi pare opportuno sottolineare perché si è fatta confusione fra i due campi. Per portare esempi che conosco, relativi alla mia attività di editor e traduttrice per Edizioni SUR, nessuna attivista di colore italiana ha trovato da ridire sul fatto che a tradurre La ferrovia sotterranea di Colson Whitehead (Premio Pulitzer 2016) e Ragazza, donna, altro di Bernardine Evaristo (Booker Prize 2019) sia stata io, una persona bianca. A nessuna è venuto in mente di polemizzare sul fatto che nel 2019 la nuova traduzione di Il colore viola di Alice Walker sia stata fatta da una bianca, Andreina Lombardi Bom. Viceversa, semmai, molte lettrici italiane di colore hanno manifestato entusiasmo per queste pubblicazioni. Come mai? Perché queste pubblicazioni sono state operazioni letterarie serie, rigorose, complesse e spiegate con onestà, e non facili operazioni di marketing e di branding. E allora non si fa confusione. La traduzione letteraria resta quello che a mio avviso deve essere: una questione di competenza e di mediazione culturale, e non di visibilità o di rappresentanza identitaria.
Mediatori competenti
Su questo tema vorrei aggiungere qualche considerazione, dato che, sia pure a sproposito, la questione di “chi può tradurre chi” è stata tirata in ballo, e non affrontarla potrebbe sembrare una sorta di rimozione. Nessuno, come si è giustamente detto, ha mai davvero sostenuto la posizione “i bianchi non possono tradurre i neri”; ma ho visto per esempio sostenere, nei commenti a un post di Facebook, la posizione secondo cui un traduttore ebreo è più indicato per tradurre i libri di un autore ebreo (l’autore del commento citava esempi di traduzioni italiane di testi di autori ebrei in cui termini relativi all’ebraismo risultavano tradotti a suo dire maldestramente, e la cui sciatteria lo offendeva). A me sembra innanzitutto una questione mal posta: ciò che si traduce è il testo, non l’autore, e l’eventuale affinità del traduttore va misurata rispetto al testo. Anche se, in effetti, negli ultimi anni si fa tantissima letteratura a partire dal proprio vissuto, dalle caratteristiche ritenute fondanti della propria identità personale, non è certo detto che una donna afroamericana islamica possa scrivere solo dal punto di vista di una donna afroamericana islamica: se scrive un romanzo dal punto di vista di un campione di basket, sarà opportuno trovare un traduttore che abbia dimestichezza con il basket, a prescindere dal genere, dal colore e dalla religione. Ma non solo: la traduzione non è semplicemente un fatto di competenza lessicale, è anche, e molto, un fatto di efficacia, scorrevolezza, naturalezza nella resa italiana; anche un grande giocatore o esperto o appassionato di basket non sarà il traduttore migliore di quel romanzo, se non possiede la tecnica, guadagnata con l’esperienza, che gli permette di evitare calchi e farraginosità, di scrivere frasi che suonino italiane nella sintassi.
Mi viene però facile capire – mutatis mutandis, ovviamente – la frustrazione che il lettore ebreo esprimeva nel suo commento: a distanza di vent’anni ancora ricordo la rabbia provata nel leggere, nel 2002, i Diari di Kurt Cobain nell’edizione Mondadori, in una traduzione frettolosa che mi pareva mostrare totale ignoranza del contesto di provenienza di quelle pagine, ossia la scena musicale di Seattle (basti dire che il musicista e produttore Calvin Johnson veniva confuso con lo stilista Calvin Klein). La mia rabbia nasceva dalla constatazione di un’incompetenza ma veniva acuita dal fatto che la scena grunge aveva formato (e ancora forma!) una parte importante della mia identità culturale, e quindi una parte di me si sentiva mal rappresentata, ignorata: perché non avevano fatto tradurre il libro a qualcuno che quell’identità in qualche modo la condivideva? (Non l’avrei tradotto meglio io?) Non a caso, si trattava di un bestseller annunciato, importato dagli Stati Uniti e uscito in contemporanea in tutto il mondo, circostanza che sempre comporta il restringersi dei tempi di produzione, e i rischi di frettolosità e scarsa cura. Un tipo di lavoro editoriale diverso, però, garantisce risultati di altro livello – anche in fatto di “rappresentanza” delle voci.
Nel 2017 ho tradotto per Edizioni SUR Anatomia di un soldato di Harry Parker, scritto da un soldato britannico reduce dal Medio Oriente. L’ambiente dell’esercito mi era totalmente sconosciuto, ma era fondamentale chiamare le cose col nome con cui le avrebbe chiamate un soldato italiano; da editor, ho quindi chiesto di rileggere tutti i capitoli in cui compariva gergo militare a un soldato italiano di professione che era stato in missione negli stessi luoghi negli stessi anni. Una volta pubblicata, la traduzione ha circolato ampiamente negli ambienti militari, ricevendo unanimi elogi. E quindi, certo: se ci sono testi che riflettono l’appartenenza dell’autore a una certa comunità, che ne contengono la lingua specifica (non è, ripeto, il caso di “The Hill We Climb”), nel tradurli è necessario l’apporto di chi quella comunità la conosce bene; questo apporto è precisa responsabilità dell’editore farlo venire dal traduttore, oppure da un consulente tecnico. Ma ciò è diverso dal dire, con un certo essenzialismo, che se un autore appartiene a una certa minoranza il traduttore più adatto è una persona che appartiene a quella stessa minoranza.
E un consulente è cosa ben diversa da un sensitivity reader, figura che negli ultimi anni si sta affermando nell’editoria statunitense, in particolare nel settore young adult: si tratta di lettori professionisti a cui si affida il compito di verificare che il testo in via di pubblicazione non contenga rappresentazioni inesatte, stereotipate, offensive di una certa comunità, o linguaggio “problematico”. È facile capire che buona parte del patrimonio della letteratura mondiale, da Catullo a Charles Bukowski, non passerebbe un simile esame. L’idea di promuovere una letteratura che sia in qualche modo incapace di nuocere mi sembra l’esito ultimo di un’editoria legata a un imperativo commerciale: quello di non perdere lettori, di non scontentare il cliente, di prevedere e prevenire i reclami – specie in un contesto in cui i reclami, espressi sui social network e amplificati dalle “bolle”, si trasformano in rovinosi tweetstorm. (E purtroppo questa tendenza non è propria dei soli grandi gruppi editoriali: negli Stati Uniti l’editore indipendente Counterpoint ha annullato l’uscita dell’ultimo romanzo di Bruce Wagner in seguito, sostiene l’autore, al suo rifiuto di cambiare nome a un personaggio che si autodefinisce Fat Joan, «Joan la Cicciona»; in Olanda, la piccola casa editrice young adult Blossom Books ha espunto dalla sua edizione per ragazzi dell’Inferno di Dante il nome di Maometto, per non «ferire inutilmente» – ha dichiarato la editor – la sensibilità dei giovani lettori al momento di vederlo punito nella nona bolgia come fondatore dell’Islam).
La visibilità del traduttore
C’è un ultimo punto che mi interessa toccare, perché è stato molto toccato in questi giorni a proposito della vicenda Gorman: quello della visibilità del traduttore. Come ho detto, nel caso della traduzione olandese di “The Hill We Climb” la richiesta di comparire come traduttore equivale a una richiesta di visibilità per via del carattere commerciale e pubblicitario dell’operazione. Ma quando invece parliamo di traduzione letteraria vera e propria? Il traduttore deve essere invisibile, deve “scomparire” dietro l’autore? O è giusto che reclami la scena, che rivendichi un ruolo di co-autore? Dei traduttori si parla troppo poco? Un lato della questione (quello su cui più ci si accapiglia) a me pare irriducibilmente soggettivo: a seconda della sensibilità personale, alcuni traduttori vorranno concepirsi come trasparenti, altri come co-creatori. Però alcune osservazioni oggettive è possibile farle: negli ultimi vent’anni è innegabile che il mestiere del traduttore abbia acquisito uno status di maggiore visibilità. Esistono decine di corsi e master di traduzione, e appositi convegni; i traduttori vengono intervistati alla radio e sui giornali; un supplemento culturale come “Tuttolibri” della Stampa ha una rubrica “Diario di traduzione”; ci sono editori che scrivono il nome del traduttore in prima di copertina, che aggiungono alla biografia dell’autore quella del traduttore, che pubblicano note del traduttore in appendice al testo; ci sono traduttori letterari che, sui social network, hanno centinaia se non migliaia di follower. Ma la reale condizione del traduttore come lavoratore è migliorata?
Sette anni fa, i mancati pagamenti dei traduttori letterari erano pratica abbastanza comune da far nascere un’iniziativa di denuncia: “Editori che pagano”, un blog in cui, non volendo nominare esplicitamente gli insolventi per timore di ritorsioni legali, ciascun traduttore nominava quelli che l’avevano pagato. Oggi va meglio? Di storie di grave insolvenza nell’ambiente forse se ne sentono meno (alcuni di quegli editori in difetto coi pagamenti nel frattempo hanno chiuso); esiste un attivo sindacato dei traduttori (che è riuscito a far ottenere ai traduttori editoriali, durante la pandemia, una misura di ristoro economico di tutto rispetto se paragonata a quelle di altre categorie: fino a 3.000 euro di contributo). Tuttavia, va ricordato che una porzione consistente dell’industria editoriale basa la sua produzione di traduzioni non su contratti coi singoli professionisti ma sull’appalto a studi e service editoriali in cui il lavoro del traduttore rischia di essere meno retribuito, meno tutelato, più invisibile.
È esemplare il caso di Errore di sistema, l’autobiografia di Edward Snowden, uscita nel 2019 per Longanesi. È un libro che ho letto in inglese e amato moltissimo perché è tante cose insieme: un thriller, un’inchiesta, una confessione personale, una riflessione sul rapporto fra il cittadino e lo stato; ed è anche ben scritto: l’autore si è avvalso dell’aiuto di Joshua Cohen, uno scrittore di conclamato talento. Insomma, ancora una volta un bestseller annunciato negli Stati Uniti, i cui diritti di traduzione saranno stati venduti agli editori europei in tempi rapidissimi e per cifre enormi; ma stavolta un libro serio, utile, non una pura operazione di marketing. Se aprite l’edizione italiana, però (uscita in contemporanea mondiale con tutte le altre), e cercate il nome del traduttore, non lo trovate: nel colophon c’è solo l’indicazione “Traduzione e redazione a cura di NetPhilo Publishing”, uno studio editoriale milanese a cui molte case editrici appaltano la lavorazione dei loro titoli. Chissà se Longanesi, tramite NetPhilo, ha fatto tradurre il libro di Edward Snowden a un traduttore maschio o femmina, esperto di spionaggio o di informatica, o a un gruppo di traduttori che hanno lavorato in parallelo a spron battuto ciascuno su un pezzetto del libro, per arrivare in tempo alla data di uscita? Quello che è certo è che non l’ha fatto tradurre a un traduttore il cui contratto prevedeva il nome sul frontespizio. E perché un editore che pubblica un libro così importante lo pubblica in questo modo, letteralmente cancellando l’identità del traduttore e sostituendola col nome di un’azienda (e quindi, è lecito supporre, curando fino a un certo punto la qualità della traduzione)? Non lo sapremo mai. A meno che qualche indignato non vada a chiederne conto alla casa editrice, ma sembra che su certe operazioni i tweetstorm non scattino.
Concludo. A sinistra, nella vicenda di Amanda Gorman molti hanno visto, comprensibilmente, un’occasione per parlare del motivo per cui alcuni soggetti, o alcune identità, sono meno rappresentati in un certo settore: del motivo per cui “non ci sono abbastanza XXX nella stanza”; a me è sembrata una buona occasione per parlare in maniera un po’ dettagliata di come è fatta, la stanza. Ci sono operazioni e pratiche editoriali che favoriscono la mediazione dei contenuti letterari in tutta la loro complessità e ricchezza, che creano veri ponti, che valorizzano la traduzione; ci sono operazioni e pratiche editoriali che favoriscono la banalizzazione, la riduzione della complessità, che creano solo rotte di importazione e la traduzione, in fondo, la mortificano.
SOSTIENI MICROMEGA
Ti è piaciuto questo articolo?
Per continuare a offrirti contenuti di qualità MicroMega ha bisogno del tuo sostegno: DONA ORA.