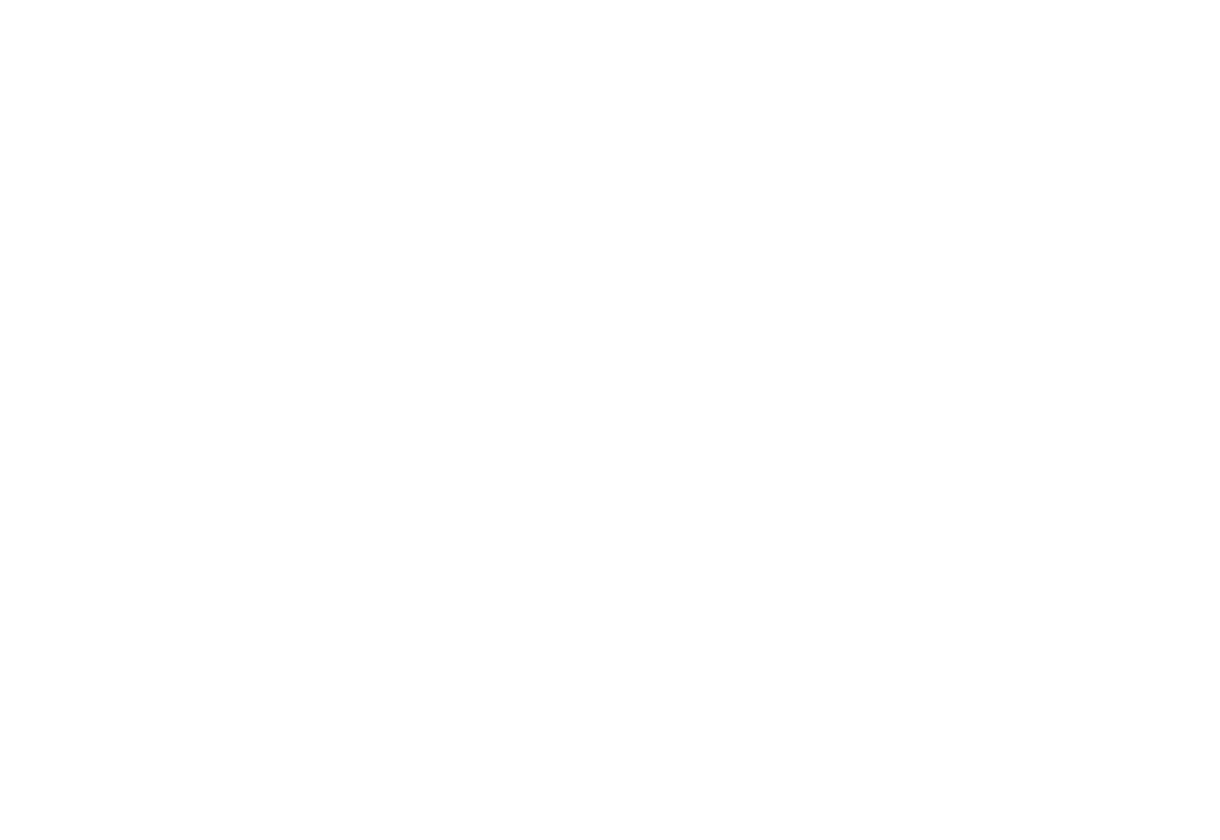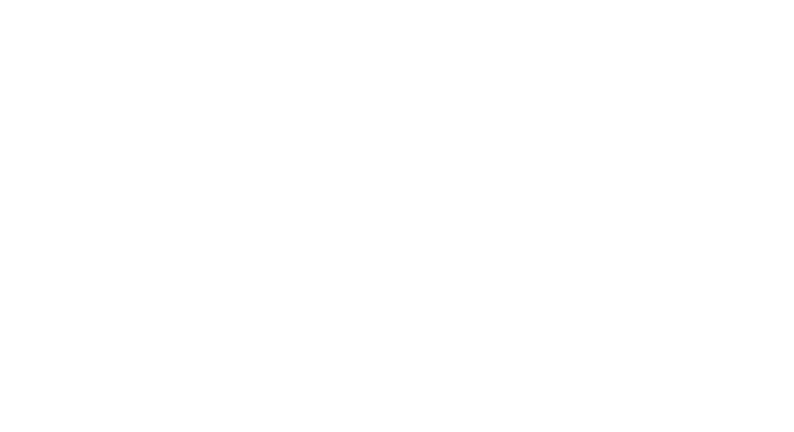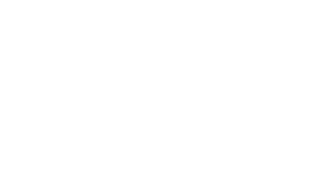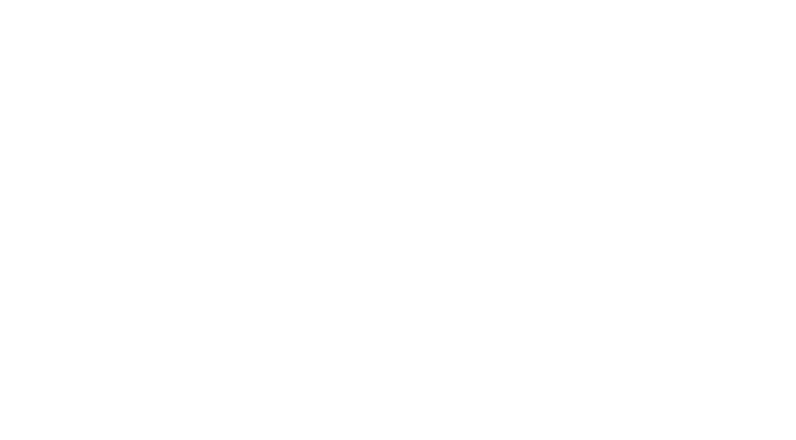L’alienazione sociale tra critica e norma
In "L’alienazione sociale oggi. Una prospettiva teorico-critica" (Carocci, Roma 2023), Eleonora Piromalli affronta il tema di una nuova teoria dell'alienazione, alla luce del dibattito contemporaneo e a partire da una ricca fenomenologia del problema.
Emanuele Lepore
L’ultimo libro di Eleonora Piromalli, L’alienazione sociale oggi. Una prospettiva teorico-critica (Carocci 2023), ha un obiettivo ambizioso: riabilitare la categoria di alienazione sociale e porla quale chiave di volta di una più ampia teoria critica delle società democratiche.
Si tratta di una traccia filosofica complessa. Per un verso occorre infatti stabilire con precisione quali fenomeni di estraneità, disagio o sofferenza ricadano sotto il concetto di alienazione sociale, e per l’altro determinare i criteri normativi in obbedienza ai quali si producono forme di vita disalienate. Tuttavia, questa doppia operazione diagnostico-normativa porta con sé un grumo di questioni teoriche e politiche di non poco conto. Affinché sia possibile definire una condizione di vita come alienata, pare necessaria una concezione “troppo forte” dell’essenza umana e delle sue realizzazioni “naturali” o appropriate. Non sono soltanto i criteri a cui questa valutazione rimanda a far problema ma anche la posizione da cui la diagnosi è condotta: essa non tradisce forse una posizione di eccessivo distacco da parte di chi la effettua rispetto al fascio di processi e rapporti affetti da alienazione sociale? In termini più prossimi alla sensibilità politico-culturale contemporanea, la questione riguarda il vantaggio, o il privilegio, che consente di indicare quali forme di vita esprimano alienazione e quali no.
Il libro di Piromalli ha il grosso merito di affrontare tali questioni direttamente, senza peraltro sorvolare sul “lungo oblio” che ha caratterizzato la nozione di alienazione negli ultimi decenni, confrontandosi criticamente anche con “alcuni recenti tentativi di riattualizzazione” (p. 13) – in primis quello condotto da Rahel Jaeggi in Alienazione (Castelvecchi 2017). È poi apprezzabile lo sforzo filosofico di transitare da una fenomenologia minima dell’alienazione alla comprensione delle determinazioni essenziali di questa specifica condizione, che l’autrice fotografa come il “farsi estraneo di ciò che è proprio” (p. 33). Riconnettendosi all’importante lavoro epistemologico condotto da Adam Schaff nel suo saggio del 1977, L’alienazione come fenomeno sociale, Piromalli intende riunire sotto questa “cifra comune” (ibidem) del farsi estraneo due dimensioni del fenomeno indagato, che riguardano rispettivamente il rapporto con le istituzioni e la circolazione psichica intra-individuale. Lungo il primo versante, la sfida è dunque quella di intervenire criticamente sui processi di autonomizzazione dei prodotti sociali – istituzioni, apparati culturali, sistemi normativi, e così via – rispetto a chi li ha effettivamente prodotti; quanto al rapporto dell’individuo con sé, l’alienazione mette capo all’estraneità di quest’ultimo rispetto alla sfera delle sue percezioni, azioni e capacità (ibidem). L’unità di questi due ambiti è dall’autrice individuata nella dimensione sociale dell’alienazione, la quale è così ricondotta alla configurazione delle società contemporanee. È il caso di notare, anche se per inciso, che su questo punto Piromalli guarda direttamente alla riflessione hegeliana e marxiana (fonte di quello che nelle prime battute del testo ella definisce modello teorico-critico di concettualizzare l’alienazione); ed è anzitutto sul campo dell’interpretazione di Marx che questo libro misura la sua distanza critica da Jaeggi e dalla tesi per cui la teoria critica d’ispirazione hegelo-marxista assumerebbe una postura “nostalgica” rispetto all’alienazione, presupponendo una formazione sociale “precedente” al dispiegarsi di tale fenomeno (pp. 95 e ss). Richiamandosi a Marx e a Hegel, Piromalli non si limita a individuare la scaturigine sociale dell’alienazione ma avanza una pretesa più coraggiosa: che a tale fenomeno sia “possibile riparare per mezzo di interventi critico-normativi sulle forme della società” (p. 33) – su questo punto torneremo brevemente nelle conclusioni.
Affermare che l’alienazione consista nel farsi estraneo di ciò che è proprio stimola una serie di riflessioni ulteriori. Viene anzitutto da domandarsi – aristotelicamente – se tale condizione sia dunque di per sé una perdita, una privazione che implica ingiustizia in quanto non prodotta da un fisiologico processo di decadimento – soprattutto nel caso dell’alienazione interna alla psiche individuale. E ancora: se essa possa essere letta come sinonimo di falsa coscienza oppure no; se l’alienazione infine coincida ipso facto con il dominio sociale o ne rappresenti una dimensione specifica. Sono questioni, quelle appena sbozzate, che Piromalli affronta nella prima parte del libro – non a caso intitolata Teoria dell’alienazione sociale –, che può essere letta come una ricca descrizione dell’alienazione per via di negazione. Il punto che l’autrice afferma con nettezza è il seguente: l’alienazione implica che i vettori di dominio assumano “la parvenza di una fattualità estranea o di un dato per sua natura intrasformabile, necessario e immutabile” (p. 53). Il solo dominio non è sufficiente per articolare un discorso sulle forme di vita alienata. Occorre infatti che si produca uno scollamento tra la struttura sociale e la percezione che di essa si ha, e che tale rapporto di estraneità si cementi come naturale: poiché le determinazioni strutturali della società non sono percepite come il precipitato di una congerie di pratiche e processi, esse ricadono al di fuori di ogni azione critica e politica.
Tale effetto di naturalizzazione delle strutture sociali è al cuore di ciò che Piromalli definisce alienazione sovraindividuale, la quale si riconnette a quella soggettiva pratica e soggettiva psicologica: in questo senso, l’autrice individua una implicazione reciproca tra l’estraneità esperita rispetto alle coordinate architettoniche della vita associata e quella che gli individui percepiscono verso i prodotti delle loro pratiche (p. 50). Su questo secondo livello, l’alienazione sociale lambisce il perimetro dell’ideologia, in quanto anch’essa è riprodotta nelle azioni individuali quotidiane. Nondimeno, secondo Piromalli ‘alienazione’ e ‘ideologia’ non coincidono perfettamente, essendo la seconda categoria utilizzata in un senso molto ampio di sistema di credenze o di pensiero (p. 179). È dunque la cristallizzazione di tali sistemi che può produrre alienazione ideologica, allorquando questi siano vissuti come alcunché di estraneo all’azione degli individui che li sottoscrivono e ne reiterano i moduli o le prescrizioni. In una società caratterizzata da sfere di alienazione anche economica e politica, non stupisce che tale farsi estraneo di ciò che è proprio si profondi anche nella sfera intra-individuale, dando forma al soggetto sia verticalmente – cioè nel rapporto con le proprie capacità e la più ampia dimensione “interiore” – sia orizzontalmente – impregnando così la logica dell’intersoggettività (p. 49).
È nell’ottavo – e ultimo – capitolo del libro che Piromalli si produce in una movenza filosofica che trapassa dalla diagnosi alla determinazione normativa, di fatto mostrando i possibili sviluppi delle sue ricerche sull’alienazione verso una più sistematica concettualizzazione delle società democratiche. La premessa argomentativa è lineare: indagata in senso critico, la categoria di alienazione mostra di presupporre non soltanto criteri di valutazione della vita umana più o meno impegnativi dal punto di vista antropologico, bensì anche “il proprio opposto normativo”, ovverosia la disalienazione (p.213). Ciò che appare – anche per ragioni linguistiche – come secondo è in verità il primo nell’ordine logico: è perché vi è un “principio di una comunicazione e un’interazione il più possibile scevra da rapporti di dominio, forme di oppressione, blocchi e repressioni” che si dà la possibilità di articolare una critica dell’esperienza sociale alienata (p. 215).
Chiarendo subito che non si tratta di un modello sociale improntato alla piena trasparenza, Piromalli avanza piuttosto l’idea di una società democratica deliberativa, in cui una maggiore partecipazione comunicativa squadernerebbe pratiche di riconoscimento non solo intersoggettive, ma anche intra-individuali – richiamandosi alla già menzionata immagine degli assi verticale e orizzontale dell’esperienza umana, ripresa dall’antropologia filosofica di Roberto Finelli (cf. Per un nuovo materialismo, Rosenberg & Sellier 2018). La disalienazione, nella prospettiva di Piromalli, passa dunque per un irrobustimento dei circuiti comunicativi e deliberativi nel senso dell’autodeterminazione individuale e collettiva (p. 218).
Come si è appena visto, la teoria dell’alienazione di Piromalli apre a sviluppi prettamente filosofico-politici – e l’auspicio è che l’autrice possa dedicare ad essi prossimi lavori. In tal senso, avanziamo un appunto sul rapporto tra ideologia e alienazione, poiché una ulteriore riflessione su questo punto può contribuire a rafforzare la comunicazione tra i due poli della teoria di Piromalli, quello diagnostico e quello normativo.
Nel libro, la categoria di ideologia è assunta in un senso molto ampio per indicare un sistema di credenze o di pensiero. La funzione di legittimazione dell’ordine sociale esistente, che molta filosofia contemporanea attribuisce esattamente al dominio dell’ideologico – da Stuart Hall a Judith Butler e Slavoj Žižek e Jodi Dean – è piuttosto ricondotto alla figura della falsa coscienza. A nostro avviso, per potere immaginare forme istituzionali e democratiche che consentano un maggiore respiro deliberativo, e da ultimo la riappropriazione di ciò che è in prima battuta venuto estraniandosi dalla sfera individuale e collettiva, occorre riattingere una concettualizzazione più ricca dei processi ideologici. La parvenza di estraneità che gli assetti economici, culturali e politici assumono è infatti orientata alla naturalizzazione di precisi rapporti sociali, marxianamente individuati nel modo di produzione capitalistico: essa dipende precisamente dall’espressione ideologica del capitale, la quale costituisce un agglomerato – talvolta un sistema – ideale che legittima l’ordine esistente dislocandolo in una sfera, quella della naturalità, che de jure non è lambita dall’azione individuale e collettiva.
Una considerazione critica del modo di produzione capitalistico, cioè, suggerisce di riunire le due figure – ideologia e falsa coscienza – che Piromalli adotta e di procedere piuttosto a una distinzione dell’ideologico rispetto alla teoria che a quest’ultimo si rivolge criticamente. In altri termini, si tratta di fare emergere il vettore che surdetermina tutte le altre forme di estraneità e le mette a sistema, proprio osservando l’esigenza di precisione epistemologica a cui Piromalli tiene fede nel suo libro.
In questo senso, è possibile individuare nel dispiegamento ideologico dell’egemonia del capitale una delle principali resistenze all’avanzamento democratico, sia istituzionale sia culturale (che per Piromalli custodisce prospettive di disalienazione), verso un principio di sviluppo onnilaterale dell’individuo – per richiamarci al dettato marxiano del 1875. D’altro canto, se si stringono le diverse sfere dell’alienazione sociale alla riproduzione di quella peculiare estraneità che è il capitale, allora l’effetto di naturalizzazione dell’ordine sociale è sì da collegare al modo in cui gli individui esperiscono i frutti delle loro attività – elemento meritoriamente presente nella prospettiva dell’autrice. Resta tuttavia da specificare quale più specifico rapporto vi sia tra l’alienazione della sfera pratica della vita umana e il lavoro, tenendo conto delle diverse modalità in cui i rapporti lavorativi vengono configurandosi in una precisa congiuntura storico-sociale, per sondare quali pratiche e dispositivi di democratizzazione possano scorgersi nella capillare ristrutturazione dei rapporti lavorativi. Un ulteriore sforzo di connessione tra una teoria critico-normativa della democrazia e una riflessione filosofica sulla forma dei rapporti sociali, a partire dal lavoro e dal salario, appare tanto più necessario quanto più si apprezza il contributo che l’ultimo libro di Eleonora Piromalli offre agli studi teorico-critici.
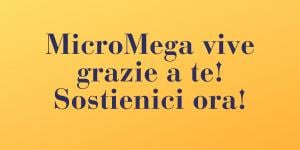
Ti è piaciuto questo articolo?
Per continuare a offrirti contenuti di qualità MicroMega ha bisogno del tuo sostegno: DONA ORA.