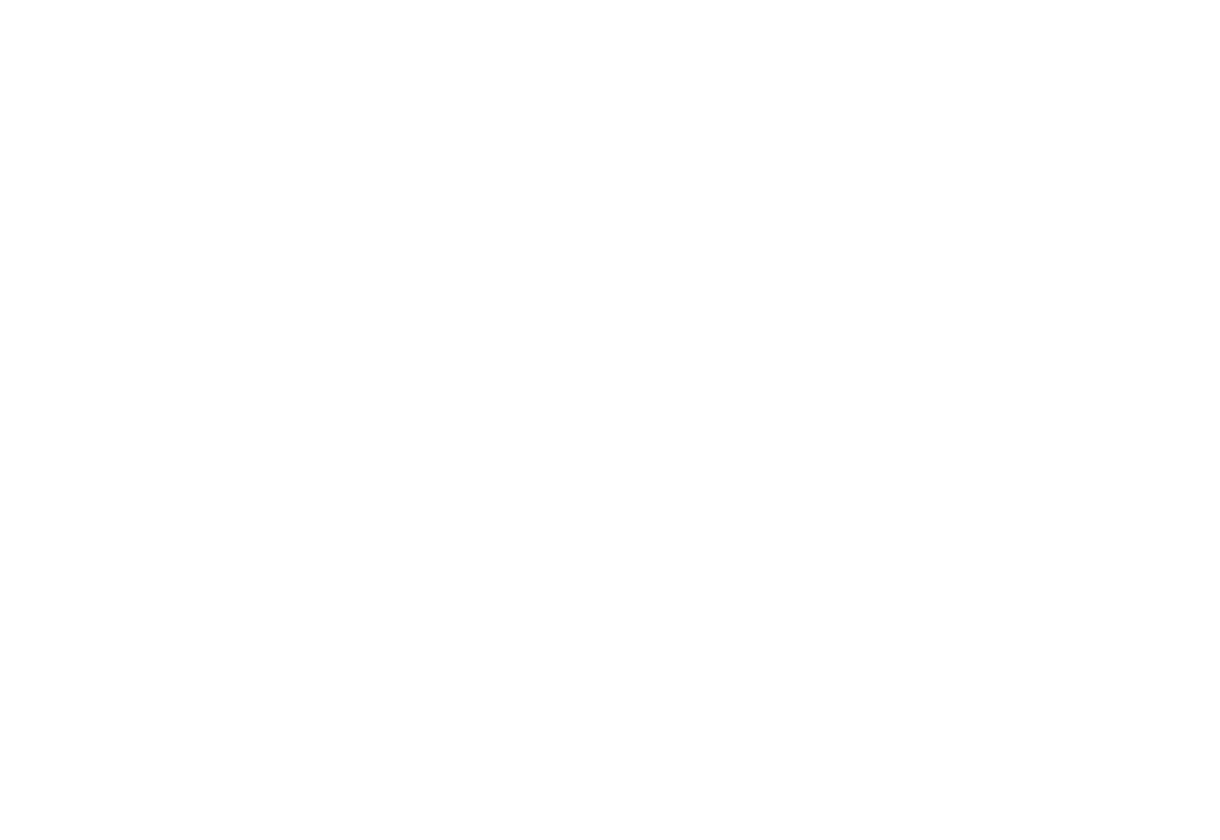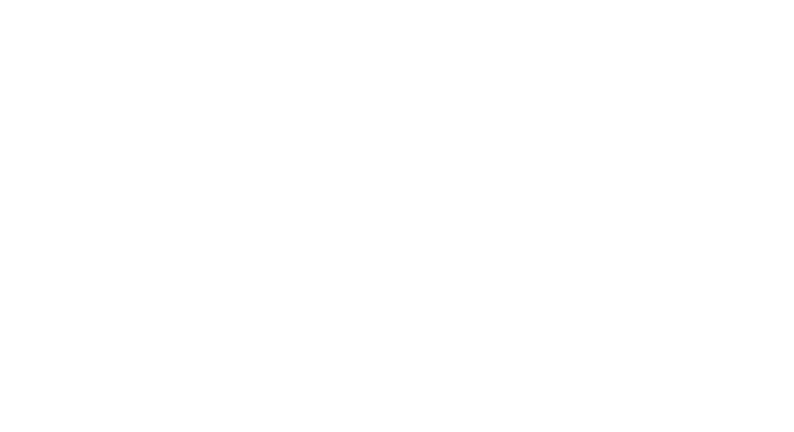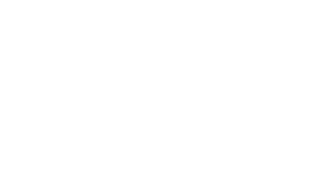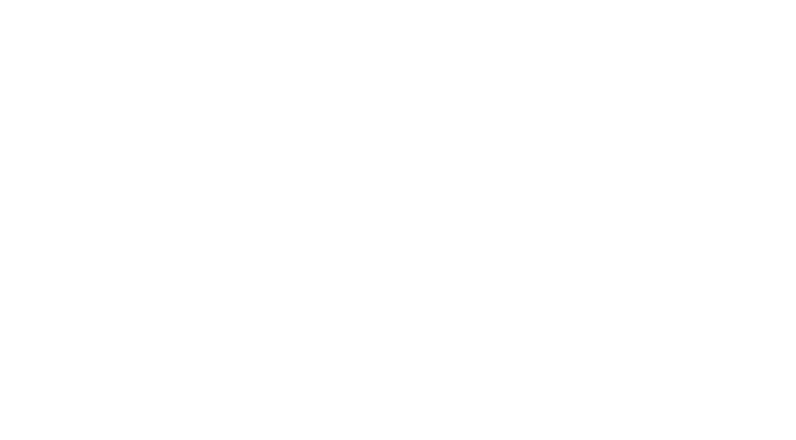Mappe del nuovo mondo: Mahasweta Devi e Salman Rushdie
In questa puntata di "Mappe del nuovo mondo": "La preda e altri racconti" di Mahasweta Devi e "I figli della mezzanotte" di Salman Rushdie. Con un saggio di Alessandra Consolaro.
Andrea Maffei
Mahasweta Devi, La preda e altri racconti, trad. it. di Babli Moitra Saraf e Federica Oddera, Einaudi, 2004
Quante Indie esistono? Forse infinite, come i vicoli di Delhi che paiono incessantemente generarsi l’un dall’altro, come il Chand Baori a Jaipur, dove ogni scalinata tramuta in una seconda identica e in una terza ancora e ancora, in una ipnotica malia, come nelle fantasie di Borges o di Escher. Possiamo ridurle però fondamentalmente a due: quella del concreto e quella del sogno, anche se in sempre incombente contaminazione. La scrittrice Mahasweta Devi (1926-2016) ha provato per lo più a raccontare la prima. Non è certo stata l’unica a ritrarre le miserie indiane (pensiamo al massiccio Un perfetto equilibrio di Rohinton Mistry, al più noto Il dio delle piccole cose di Arundhati Roy, a Chiara luce del giorno di Anita Desai o ancora, passando alla lingua hindi, al mitico Godan: il dono della vacca di Premchand), ma è con ineguagliato piglio realista che la nostra racconta vicende spesso segnate da una sconvolgente violenza. È la stessa Devi a definire il suo linguaggio brutale, a volte letale. Ad esempio il celebrato racconto Draupadi (il nome viene dal poema sacro Mahābhārata), che tratta d’uno stupro. Oppure il romanzo La cattura (per Theoria), dedicato alle sommosse contadine nel Bengala occidentale, perché nell’autrice si riconosce una precisa visione di lotta di classe e nel racconto Sementi un contadino esasperato accompagna il suo malik (il padrone) nel campo di riso e gli sfonda la testa con una grossa pietra. L’autorità appare ogniqualvolta predatoria, corrotta. Il debole è schiacciato: Di fronte alla fatica di un bracciante sciancato che per ordine del malik trascinava un carro di riso al mercato, domandai al malik, “Perché non usi i buoi, invece?” E lui mi rispose, “Se sotto questo sole il bue muore, ci perdo migliaia di rupie. Quello è solo uno schiavo. La sua vita non vale nulla”. Lo Stato è la sistematizzazione della ferocia. Così nei ventun mesi dello Stato di Emergenza decretato da Indira Gandhi tra il ’75 e il ’77, nella repressione d’ogni rivolta, nel mantenimento d’un sistema di fatto feudale, di diseguaglianze sociali (pensiamo agli adivasi del racconto Sale) e suddiviso in caste. Quest’ultimo aspetto dà anche spunto, tuttavia, a pagine di alta poetica, come quelle dell’amore contrastato fra Dinu e Dulali nella novella La statua, di sapore shakespeariano. Mahasweta Devi è considerata la maggiore scrittrice in lingua bengali, ma questa è screziata di termini urdu e hindi, di dialetti, e anche di inglese, idioma di solito attribuito all’oppressore. Abbiamo visto quanto centrale sia la questione linguistica nel post-colonialismo. La Costituzione indiana riconosce ufficialmente 22 lingue, ma alcune stime, comprendendo anche i dialetti, giungono a ipotizzare la diffusione di oltre 1.500 parlate diverse. Tale Babele linguistica naturalmente influenza largamente la letteratura (o le letterature) del Paese. È proprio a questo tema è dedicato il contributo dell’ospite di oggi, la professoressa Alessandra Consolaro, docente di Lingue e letterature moderne del subcontinente indiano presso l’Università di Torino. Un regalo per i lettori e un indispensabile viatico in questo primo viaggio di MDNM in India.
Salman Rushdie, I figli della mezzanotte, trad. it. di Ettore Capriolo, Garzanti, 1980
L’India del sogno appartiene a Salman Rushdie. Nel suo pirotecnico capolavoro, il romanzo in lingua inglese I figli della mezzanotte, suddiviso in tre libri, si esibisce in una prosa disordinata e frenetica, abbacinante e soprattutto pregna di storie, personaggi, immagini, simboli, bizzarrie. Praticamente ogni rigo offrirebbe lo spunto per un racconto autonomo, e le numerosissime divagazioni (tutto il primo tomo è di fatto excursus che precede la nascita del protagonista, e forse qui ispirazione è lo Shandy di Sterne), sconclusionate e picaresche, sono in realtà una esigua scelta fra quelle possibili. Rushdie adatta il suo stile non alla vicenda che racconta – il che è pratica già nota – ma (un po’ come nei Malavoglia di Verga) all’ambiente della narrazione: l’India febbrile caotico traffico di moltitudini umane-animali-divine-motorizzate. Protagonista e narratore è il musulmano Saleem Sinai che, nato a mezzanotte del 15 agosto 1947, in contemporanea con l’indipendenza indiana, scopre che la sua vita sarà lo specchio di quella del Paese, così come d’altronde già gli prospetta il primo ministro Nehru in un telegramma di felicitazioni. Più avanti verrà a sapere, come gli altri mille bambini nati a ridosso della mezzanotte, di disporre di poteri soprannaturali: Saleem è in grado di leggere nella mente altrui, almeno fino a che, già ragazzo, i genitori non lo sottoporranno alla pulizia specialistica del suo pantagruelico naso sempre colante, con la quale perderà ogni dote. Agli strambi eventi della sua biografia corrispondono quelli altrettanto stravaganti dell’India (un po’ come nel film Forrest Gump, di cui di recente è peraltro uscito un remake indiano: e il cinema bollywoodiano è ben presente nel romanzo di Rushdie), cosicché storia privata e pubblica si intrecciano e anzi è lo stesso Saleem a condizionare i maggiori avvenimenti, su chilometriche catene causa-effetto, ed ecco che ad esempio il suo tentativo, a dieci anni, di farsi notare da una ragazzina provoca la divisione dello Stato di Bombay. Da questo specialissimo punto di vista osserviamo dunque snodarsi la Storia indiana del secondo Novecento, dall’omicidio del Mahatma Gandhi fino al controverso Stato d’Emergenza di Indira Gandhi, dal breve conflitto sino-indiano alla guerra con il Pakistan. Al Bangladesh e, appunto, al Pakistan sono dedicate molte pagine (Rushdie vi avrebbe ambientato poi La vergogna, in Italia per Mondadori), dopo che Saleem vi si trasferisce con la famiglia, in seguito uccisa in un bombardamento, ma non prima ch’egli giochi parte attiva nel colpo di Stato del generale Ayub Khan. La narrazione oscilla nel tempo, con frequenti anticipazioni e ricordi. C’è chi ha parlato di realismo magico, e non a sproposito. C’è un catalogo infinito di mirabilia, che ai lettori richiede un’attenzione vigile, per non smarrirsi fra i sempre nuovi eventi e personaggi. Ci sono i colori vivacissimi, gli odori escrementizi e speziati: Si leva dalle mie pagine un’inconfondibile zaffata di chutney. C’è l’India comica, sacra, magnifica, allegorica e sconfinata, perché (annota Borges nel racconto L’uomo sulla soglia) L’India è più grande del mondo. Fra i più ambiziosi ed esaltanti romanzi degli ultimi decenni.
Mezzanotte e dintorni: la benedizione di Babele o un monolinguismo globalizzato?
di Alessandra Consolaro
L’egemonia globale della lingua inglese fa sì che, come già in epoca coloniale, una pletora di scrittori e scrittrici, accomunati da peculiari caratteristiche – la provenienza da ceti medio-alti, l’origine metropolitana, l’aver frequentato specifiche scuole e università e spesso la residenza all’estero – sia oggi acclamata dal pubblico europeo come l’unica voce dell’India. L’inglese è parlato correntemente dal 5% della popolazione del Paese ed è in qualche modo conosciuto dal 10%, cioè circa 75-150 milioni di persone su una popolazione di un miliardo e mezzo. Tuttavia, esiste una geografia linguistica all’interno dell’India che riconosce 22 lingue regionali, confermando ed emarginando allo stesso tempo il posto di ogni lingua nel suo contesto geografico. L’inglese, sebbene la sua forza numerica lo ponga alla pari di molte lingue cosiddette regionali, è solo una delle oltre 20 importanti lingue letterarie con una lunga storia alle spalle, tra cui hindi, urdu, tamil, marathi, malayalam e bengali, solo per citarne alcune.
Le divisioni sociali nella società indiana – casta, classe, genere, religione, appartenenza urbana e rurale – operano in parallelo alle divisioni linguistiche. Parlare di élite urbane significa riferirsi a quel gruppo di persone (ricche, di classe media, generalmente anche di casta alta) che ricevono un’istruzione con l’inglese come lingua veicolare. Ma oltre l’80% della popolazione studia in scuole che hanno una delle altre lingue indiane come lingua veicolare. La maggior parte delle letterature “regionali” serve un pubblico più vasto di quello di molti Paesi europei e le dimensioni di queste culture letterarie sono oscurate dall’idea di regionalità. Di fronte alla produzione letteraria inglese globalizzata e alla prominenza della scrittura inglese di persone di origine indiana, il regionale è diventato in qualche modo un diminutivo e limita il prestigio dei testi letterari in lingue indiane quando sono affiancati a quelli in inglese, come inevitabilmente accade.
Con la decolonizzazione la hindi divenne un simbolo di unità nazionale ed è oggi lingua ufficiale. Il 40% della popolazione indiana parla hindi, ma l’appellativo “hindi” include circa cinquanta “dialetti”, alcuni dei quali sono in realtà lingue con una lunga tradizione letteraria. Esiste una dicotomia tra la hindi come forza unificante e come potenziale minaccia alla diversità linguistica dell’Unione indiana. Il nazionalismo hindi ha spesso creato un canone letterario egemonico, perpetuando una struttura gerarchica e contribuendo alla cancellazione delle voci non hindi.
La hindi occupa una posizione ambivalente, essendo allo stesso tempo lingua di potere e lingua regionale. Come l’inglese, il suo potere egemonico è contestato, sebbene per ragioni diverse: per esempio, nel sud, dove si parlano lingue dravidiche, la hindi è simbolo del predominio culturale e politico dell’India settentrionale. Anche molte persone dalit (ex intoccabili) sostengono l’inglese, rifiutando la hindi che è necessaria per accedere ai posti di lavoro statali, ma non è sufficiente per garantire l’accesso al mondo del capitale e del potere globale, ancora controllato per lo più da persone appartenenti alle caste superiori.
In altre situazioni la hindi permette di superare i confini regionali e di far sentire la propria voce a livello panindiano. Per esempio, la poeta e giornalista adivasi (indigena) Jacinta Kerketta, che è stata inserita da Forbes India nel novero delle Self-Made Women 2022 dell’India, con la sua poesia (Angor. Brace, Miraggi, 2018) ha portato all’attenzione nazionale (e internazionale) le minacce alle culture delle popolazioni cosiddette tribali dell’India e le loro lotte di base contro le politiche sviluppistiche dello Stato indiano. Scrive in hindi ma è impegnata a promuovere la cultura in kurukh, lingua della comunità adivasi oraon cui appartiene, che come molte lingue indigene rischia di morire perché la si abbandona in favore delle lingue regionali. Le letterature dalit e adivasi si sono fortemente messe in luce negli ultimi decenni non solo come resistenza, espressione di attivismo politico, sociale e culturale, ma anche come una originale e potente espressione creativa che merita di essere meglio conosciuta.
Dal 2014, con la vittoria elettorale del BJP, il partito di destra hindu guidato da Narendra Modi, le preoccupazioni di molte popolazioni di diventare soggetti di oppressione linguistica si sono acuite. Molte istituzioni governative fanno a gara per radicalizzare ulteriormente un’egemonia linguistica ed etnonazionalista, affermando una versione standard della hindi molto sanscritizzata e lontana dalle parlate popolari. Ma per fortuna la letteratura hindi non segue necessariamente queste tendenze. Il romanzo di Geetanjali Shree Ret samadhi. Al di là della frontiera (Solferino, 2024), pubblicato originariamente nel 2018, ha conquistato le prime pagine a livello mondiale quando la traduzione americana di Daisy Rockwell ha vinto il Booker Prize internazionale nel 2022. Fino a quel momento, nessun libro in una lingua indiana diversa dall’inglese era stato nominato per un importante premio letterario internazionale e Ret samadhi è stato il primo a vincerne uno. Il romanzo inizia con un melodramma familiare urbano ma procede denunciando l’ipocrisia della classe media ed esaminando mali sociali come l’ageismo e i pregiudizi di genere, affrontando temi come il cambiamento climatico e, soprattutto, i molteplici significati della parola “frontiera”. La protagonista, un’ottuagenaria che esce dalla depressione dopo la morte del marito, dà vita a una trama che si muove con la forza di un esperimento esplosivo, abbracciando il lungo arco della storia indiana con riferimenti musicali, culinari, politici, ambientali e artistici. Il testo dipinge un’epopea narrata come una fiaba popolare, che affascina per lo stile innovativo e il ritmo della scrittura costantemente cangiante. In un momento in cui in India si sostiene ufficialmente la narrazione di una lingua hindi pura, questo testo propone al contrario un linguaggio polifonico e una grammatica non convenzionale, dove si intrecciano frasi non lineari da hindi, urdu, panjabi, sanscrito e inglese, rispecchiando l’ecosistema complesso in cui è ambientato il romanzo e tessendo una sorta di enciclopedia culturale dell’India moderna.
C’è speranza che, grazie alle traduzioni, la letteratura hindi, come anche altre letterature “regionali”, trovino finalmente il posto che loro compete sugli scaffali delle librerie mondiali ed è auspicabile che ciò dia slancio a nuove traduzioni anche nel nostro Paese. Per esempio, è deplorevole che il pubblico italiano ancora non conosca un autore come Uday Prakash, che nei suoi racconti, nelle sue poesie e nel romanzo Pīlī chatrīvālī laṛkī (La ragazza con il parasole giallo) scrive una storia nazionale alternativa, concentrandosi sulle comunità subalterne e oppresse, mettendo in luce come la vecchia struttura coloniale e la sopraffazione siano rimaste tra le élite e la leadership politica dell’India indipendente.
La traduzione permette alla hindi stessa di respirare, giocare, riflettere ed esplorare le sue possibilità. Questo è il prerequisito affinché il testo tradotto trovi dimora in un’altra lingua, dove possa stare come a casa propria, piuttosto che essere semplicemente un gradito ospite. Ciò ci ricorda il grande traduttore Kumarajiva, che visse a cavallo tra la lingua sanscrita e quella cinese 17 secoli prima di noi, perlomeno così come narrato dal grande poeta hindi Kunwar Narain nel suo ultimo poemetto Kumarjiv (Fuorilinea, 2022), che riflette sull’archetipo dell’infinita ricerca umana della verità, ma anche sull’essenza della traduzione: entrare nel mondo dell’altro aprendo la porta della lingua è come costruire una via di illuminazione tra due culture. È la celebrazione di una profonda e beata amicizia tra due lingue e culture, senza fusione, senza dominio di una sull’altra e senza rivendicazioni di perdite o guadagni, solo un incontro festoso.
Ti è piaciuto questo articolo?
Per continuare a offrirti contenuti di qualità MicroMega ha bisogno del tuo sostegno: DONA ORA.