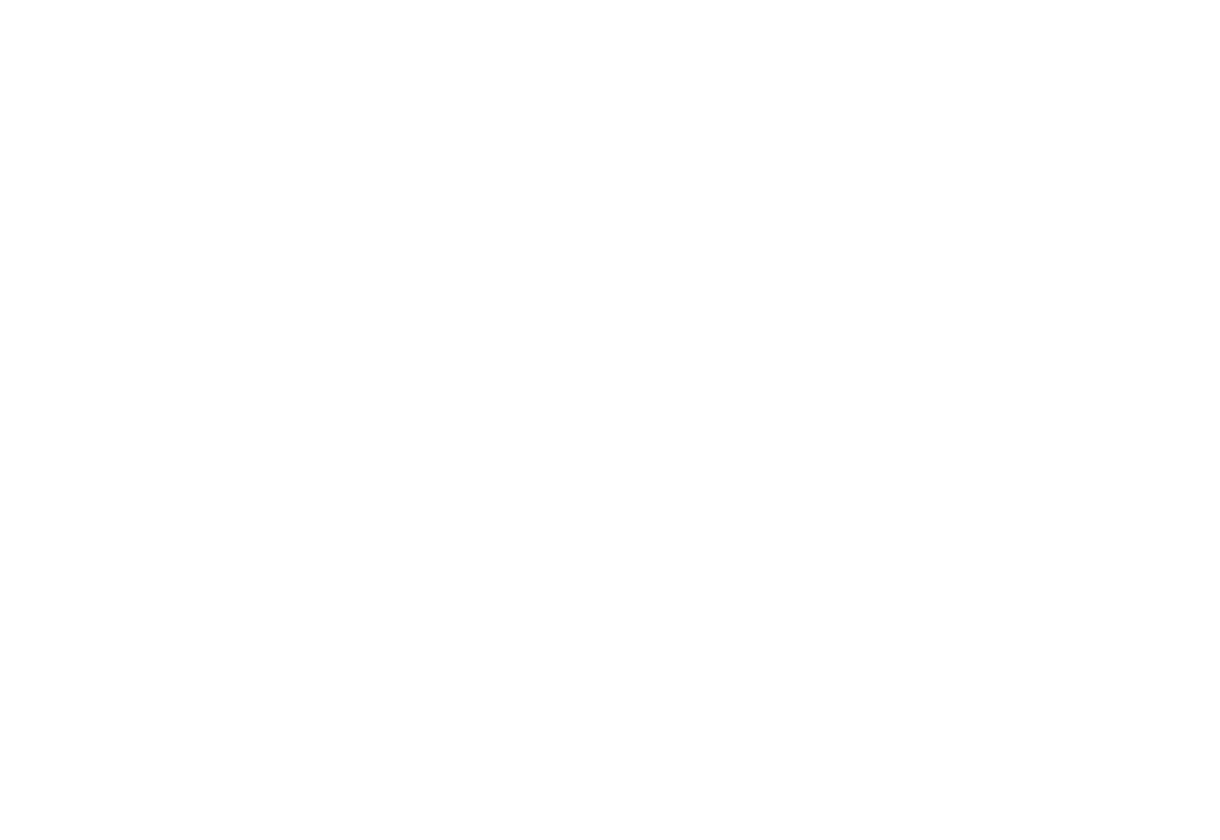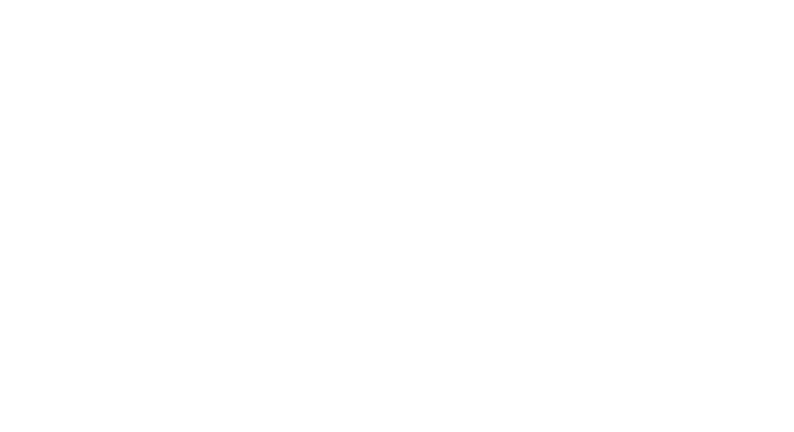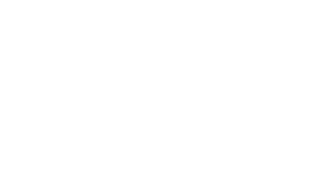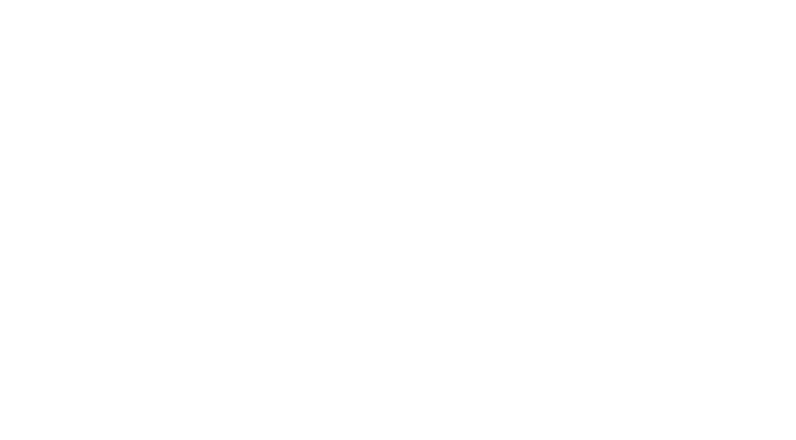Le sfide del G7 per la pace in Medio Oriente non rimangano dichiarazioni d’intenti
Dall’attacco del 7 ottobre di Hamas si è arrivati alla catastrofe umanitaria di Gaza e alla nuova fase del conflitto diretto tra Israele e Iran. Al G7 a guida italiana le principali democrazie occidentali hanno ribadito la linea della de-escalation, chiedendo di fermare l’attacco su Rafah e ribadendo la soluzione “Due popoli, due Stati”. Nonostante le insidie di altri attori non solo regionali, si tratta ora di non limitarsi alle dichiarazioni d’intenti: è il momento di una conferenza diplomatica e di un tavolo permanente di negoziatori con proposte concrete sul campo per ritrovare la stabilità in Medio Oriente.
Maurizio Delli Santi
Sono molte le insidie poste dai tanti attori regionali, e non solo, che ancora potranno contrastare la prospettiva di de-escalation su cui ha puntato il G7 di Capri dopo gli ultimi attacchi “dimostrativi” tra Iran e Israele. Ne sono un esempio le ultime notizie giunte dall’Iraq, dalla Turchia e da Rafah. La Resistenza Islamica in Iraq ha risposto con un attacco di droni su Eliat, nel sud di Israele, all’ultima esplosione in una base di milizie filo-iraniane in Iraq per cui Usa e Israele avevano comunque declinato ogni responsabilità. Nel frattempo Erdogan è tornato ad accusare Israele di genocidio e ha ricevuto il capo dell’ufficio politico di Hamas Ismail Hani: l’autocrate turco non rinuncia ad emergere come attore regionale visto il riavvicinamento tra Usa, Israele e Paesi arabi moderati in una possibile ripresa del percorso degli Accordi di Abramo, da cui l’autocrate turco è escluso. Per ultimo un raid israeliano su Rafah ha ucciso 22 persone, di cui 18 minori: potrebbe essere il preannuncio del temuto attacco finale cui il governo Netanyahu non sembra rinunciare.
Ma è bene ripercorrere con ordine la successione degli eventi per delineare meglio lo scenario. Il quadro della destabilizzazione in Medio Oriente iniziato il 7 ottobre 2023 con il massacro di 1200 israeliani e la presa di 240 ostaggi da parte di Hamas, e proseguito in oltre 6 mesi di bombardamenti di Israele su Gaza con 34.000 vittime palestinesi, è stato radicalmente mutato a seguito degli ultimi eventi. Il 1° aprile gli israeliani hanno attaccato il consolato iraniano di Damasco, dove sono rimasti uccisi diversi comandanti delle Guardie della Rivoluzione, e la notte del 14 aprile è arrivato in risposta il primo diretto attacco dell’Iran contro Israele, colpito con uno sciame di missili balistici di cui il 99% è stato comunque intercettato e reso inoffensivo. Subito dopo in una nota diplomatica all’Onu la rappresentanza iraniana ha indicato di avere dato “una risposta all’aggressione del regime sionista contro le sedi diplomatiche a Damasco” sulla base della legittima difesa prevista dall’articolo 51 delle Nazioni Unite, e ha precisato che “se Israele non commette altri errori, la questione può dirsi conclusa”. Le analisi internazionali hanno posto in luce che prima dell’attacco l’Iran aveva allertato i vicini Paesi arabi interessati al sorvolo dello spazio aereo, e quindi in qualche misura gli Usa e Israele erano stati avvertiti. Inoltre si è sottolineato che alla difesa aerea di Israele hanno contribuito le intercettazioni satellitari e radar degli Stati Uniti e i caccia inglesi e francesi, ma si è parlato anche di un ruolo – Al Jazeera lo ha definito “scioccante” – della Giordania (paese con una forte presenza palestinese) intervenuta ufficialmente per difendere il suo spazio areo, e di altri Paesi arabi come Emirati e Arabia Saudita che avrebbero fornito importanti dati informativi. Il clima però è tornato ad essere rovente dopo le dichiarazioni dei leader israeliani che hanno rilanciato la volontà di dare una ulteriore risposta. Sono seguite altre minacce di ritorsione da parte iraniana che ha annunciato l’impiego stavolta di “armi sinora mai adoperate”. La notte del 19 aprile è seguita dunque la reazione di Israele con attacchi in territori libanese, siriano e iraniano che sono stati ritenuti “contenuti”, anche se mirati a obiettivi di interesse strategico, come basi aeree e zone vicine a centri di sviluppo del nucleare iraniano: una sorta di avvertimento per far capire che Israele è capace di colpire nei punti giusti e in profondità. Dall’Iran stesso sono venute comunque dichiarazioni volte a minimizzare la dimensione degli attacchi israeliani: un segnale forse per puntare anch’esso stavolta alla de-escalation, probabilmente pure per rassicurare la popolazione iraniana.
Una prima riflessione si impone sul ruolo ora assunto dai Paesi arabi “moderati”: il mondo arabo sunnita non si è schierato ancora in maniera netta contro Israele, nonostante il dramma umanitario dei palestinesi Gaza. A sottolineare il cambiamento dello scenario è stato il Times of Israel. Ha ricordato il monito biblico “Il popolo d’Israele abiterà da solo e non sarà annoverato fra le nazioni, Numeri 23:9”, sostenendo esattamente il messaggio opposto: “Israele non può cavarsela da solo e deve tenere conto degli altri paesi quando prende decisioni militari, politiche e regionali”.
I Paesi Arabi “moderati” sembrano dunque valutare anch’essi con preoccupazione la minaccia per la stabilità dell’area del regime degli Ayatollah e del suo “Asse della Resistenza”, la rete dei proxies schierati nella “mezzaluna sciita” degli Hezbollah libanesi, delle milizie irachene e siriane, degli Houthi yemeniti che bloccano il Mar Rosso, oltre che della stessa Hamas sunnita. Come emerge dalle stesse narrazioni dei leader iraniani, lo sciismo integralista dell’Iran persegue ancora un’ideologia apocalittica che oltre a mirare alla “distruzione dell’entità sionista” rivendica di essere la vera guida della umma musulmana. Peraltro secondo diversi analisti l’attacco del 7 ottobre di Hamas rivolto a rilanciare l’attenzione sulla questione palestinese in realtà sarebbe stato orchestrato o comunque avallato dall’Iran per far naufragare il processo degli Accordi di Abramo che nel 2020 aveva avvitato a nuove intese tra Usa, Israele e mondo arabo sunnita, una fase che per l’Iran avrebbe portato al suo definitivo isolamento e nell’ottica di Hamas un progressivo disconoscimento delle istanze palestinesi. Tra i più attenti alla minaccia iraniana c’è l’Arabia Saudita sunnita che avrebbe dovuto aderire agli Accordi e che pur avendo intrapreso aperture con l’Iran (per ultimo aveva accettato la tregua nel conflitto yemenita) teme l’affermazione delle sue mire sui luoghi sacri musulmani in territorio saudita dopo essere stata evocata da Khamenei come “traditrice della Gerusalemme musulmana”. C’è poi il rischio incombente dell’avanzamento del programma nucleare iraniano che preoccupa anche gli altri Paesi arabi sunniti, come gli Usa e soprattutto Israele.
In questi scenari è emerso ragionevolmente – probabilmente anche per il clima di protesta generale dell’opinione pubblica occidentale dopo le stragi di Gaza – un ruolo di moderazione svolto dagli Usa, principale sponsor di Israele, ma anche delle altre democrazie occidentali del G7, il forum dei paesi più industrializzati rappresentati da Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Germania, Italia, Giappone e Canada, quest’anno sotto presidenza italiana.
Il 19 aprile, nello stesso giorno degli attacchi israeliani in Iran, il documento finale del G7 riunitosi a Capri ha tracciato la linea dei ministri degli Esteri e dell’Alto rappresentante dell’Unione europea per gli Affari esteri Josep Borrell . In esso si esprime la condanna “nei termini più forti dell’attacco diretto e senza precedenti dell’Iran contro Israele del 13 aprile, che Israele ha sconfitto con l’aiuto dei suoi partner”, ma si sottolinea la “pericolosa escalation” e l’esortazione per “tutte le parti a lavorare per prevenire ulteriori escalation”. Il comunicato si sofferma poi sulla crisi di Gaza partendo dalla premessa che “tutte le parti devono astenersi da azioni unilaterali che minano la prospettiva di una soluzione a due Stati”. Segue la dichiarazione anche più netta di un impegno del G7 “per una pace duratura e sostenibile basata sulla soluzione dei due Stati e sulla creazione di uno Stato palestinese indipendente con garanzie di sicurezza per Israele e i palestinesi”. C’è quindi il richiamo per “l’aumento dei livelli di violenza dei coloni” contro le comunità palestinesi che “devono essere chiamati a rispondere delle loro azioni”, e la valutazione che “una soluzione praticabile al conflitto può essere solo il risultato di uno sforzo regionale coordinato”: un chiaro monito affinché Israele tenga conto dei Paesi Arabi che non lo hanno ancora condannato all’ isolamento internazionale.
Il G7 si pronuncia anche sulla questione ora più critica per il governo Netanyahu: conferma l’opposizione “a un’operazione militare su vasta scala a Rafah, che avrebbe conseguenze catastrofiche sulla popolazione civile”. Il tema è dibattuto per vari profili, a cominciare dalla mancata attuazione della recente Risoluzione del Consiglio di Sicurezza 2728 che imponeva il cessate il fuoco già per il Ramadan. Dopo l’attacco iraniano e le incertezze sul rilascio degli ostaggi da parte Hamas il premier israeliano Benjamin Netanyahu sembra aver ritrovato consensi nel suo gabinetto per sferrare l’attacco decisivo a Rafah, la città più meridionale della Striscia. L’obiettivo è di “completare l’eliminazione di Hamas”, ma la stessa hasbara degli estremisti israeliani lascia presupporre qualcosa di più sconvolgente per 1,4 milioni di palestinesi presenti nell’area: questi prefigurano una nuova Nakba (in arabo catastrofe), l’esodo forzato cui furono costretti 700.000 arabi palestinesi ne 1948 dopo la nascita dello Stato di Israele. Si tratta di una prospettiva che preoccupa i Paesi arabi, soprattutto il vicino Egitto che teme per la stabilità interna causata da una ondata migratoria. Per quanto emerso al margine del G7, gli stessi ministri degli esteri hanno manifestato preoccupazione che la loro esortazione possa non avere seguito, tanto che hanno voluto ribadire almeno l’appello “per un piano credibile e attuabile per proteggere la popolazione civile locale e rispondere ai loro bisogni umanitari”. Alcune analisi parlano anche di una possibile intesa tra Usa e Israele che vorrebbe quest’ultimo avere accettato l’imposizione di evitare l’escalation con l’Iran in cambio del via libera all’attacco su Rafah, sebbene con rassicurazioni per un intervento mirato e che garantisca l’evacuazione dei civili. Sembrano perciò seriamente fondate le preoccupazioni su cosa deciderà Israele: per il giornale israeliano d’opposizione Haretz c’è il rischio della strategia distorta di Netanyahu che strumentalizza la linea dell’ultradestra sionista e dei coloni ricercando l’escalation per mantenersi al governo e salvarsi dai processi una volta costretto alle dimissioni.
Le questioni mediorientali sono ancora ambigue e piene di insidie, anche per le posizioni che assumeranno Russia e Cina, anch’esse al momento orientate alla moderazione. Ma molto dipenderà dalla evoluzione degli eventi perché non può escludersi un loro sostegno all’Iran. Nel complesso quadro regionale non va nemmeno sottovalutata la ricordata posizione della Turchia di Erdogan, paese non arabo che comunque non ha rinunciato a promuovere la sua leadership nel mondo musulmano schierandosi apertamente contro Israele.
In ogni caso sarà importante che l’Occidente insista sulla linea della moderazione e della diplomazia per fermare l’escalation, non limitandosi però alle dichiarazioni d’intenti: occorre che si promuova quanto prima in concreto una piattaforma di confronto – potrebbe essere una conferenza diplomatica e/o un “tavolo permanente” di negoziati con proposte specifiche sul campo – per un futuro di pace in tutti i Territori Palestinesi Occupati. Israele dovrà essere convinto a rispettare la Risoluzione 2728 e sarà necessario che le parti valutino l’ipotesi attualmente al vaglio dei negoziatori occidentali su cui occorrerà però acquisire il consenso del mondo arabo, e soprattutto l’adesione della popolazione palestinese: si pensa a un’ Autorità palestinese riformata, realmente rappresentativa dei palestinesi costruttori di pace, non compromessa né con l’accondiscendenza e il clientelismo di Abu Mazen né con gli esponenti più radicalizzati, e a un deciso ridimensionamento dei territori abusivamente occupati dai coloni di Israele. Si dovrà parlare probabilmente anche di un’Autorità di transizione affidata alle garanzie delle Nazioni Unite e/o ad una forza multinazionale di Stati occidentali e del Mondo Arabo. La soluzione “Due popoli, due Stati” rimane dunque ancora fondamentale per ricostruire la stabilità dell’area. 
CREDITI FOTO: ANSA / Presidenza Consiglio dei Ministri
Ti è piaciuto questo articolo?
Per continuare a offrirti contenuti di qualità MicroMega ha bisogno del tuo sostegno: DONA ORA.